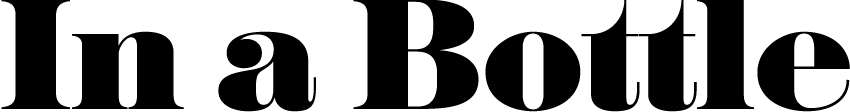MILANO – L'impronta idrica del vino è un fattore cruciale che evidenzia la quantità di acqua dolce utilizzata lungo l'intera filiera produttiva, dalla vigna alla bottiglia. Comprendere e ottimizzare l'uso dell'acqua è oggi fondamentale per la sostenibilità e la resilienza del settore vitivinicolo, specialmente in aree soggette a stress idrico e cambiamenti climatici.
L’impronta idrica
L’“impronta idrica” (in inglese water footprint) rappresenta il volume totale d’acqua dolce consumata e/o inquinata per la produzione di un bene o servizio, misurando tre componenti: acqua verde (pioggia), acqua blu (acqua superficiale o sotterranea irrigata) e acqua grigia (quantità necessaria a diluire gli inquinanti).
Nel caso della viticoltura e della produzione di vino, questo indicatore aiuta a comprendere quanto l’acqua, risorsa preziosa e spesso sotto stress, sia implicata lungo l’intera filiera, dalla vite alla bottiglia.
In Italia, dove l’agricoltura rappresenta una quota rilevante del prelievo di acqua dolce nazionale, il tema assume un rilievo particolare: ad esempio, il settore agricolo italiano assorbe l’85% dell’impronta idrica nazionale nel periodo di riferimento.
Quanta acqua serve per un bicchiere di vino?
Per avere un ordine di grandezza, alcune stime italiane indicano che un singolo bicchiere di vino (circa 0,125 litri) ha un’impronta idrica media di circa 88 litri di acqua dolce.
Altre ricerche più recenti su zone specifiche (es. bottiglie da 0,75 litri in Piemonte) indicano valori medi pari a circa 881 litri per bottiglia, quindi all’incirca 117-120 litri per bicchiere se si divide per sei bicchieri standard.
Ecco alcuni punti chiave:
- La parte maggiore dell’impronta è costituita dall’acquaverde (pioggia assorbita dalla vite) piuttosto che dall’irrigazione (acqua blu).
- Il valore varia molto in funzione del vigneto, della zona geografica (sud/centro/nord Italia), del tipo di uva, del grado di irrigazione e delle pratiche agronomiche.
- Un numero comparativo: la media globale per un bicchiere di vino è stimata in circa 109 litri.
Il contesto italiano: driver, sfide e buone pratiche
Nel contesto italiano della viticoltura si evidenziano alcuni aspetti specifici:
- Il Paese è tra i primi produttori mondiali di vino per volume e valore, con ampia diffusione territoriale della viticoltura.
- Molte zone vitivinicole italiane si trovano in aree con risorse idriche meno abbondanti (centro e sud), dove la gestione dell’acqua diventa cruciale.
- Tra le buone pratiche: miglioramento dell’efficienza irrigua, recupero delle acque di processo nelle cantine, innovazione agronomica (ad esempio sesti d’impianto, gestione della chioma, ecc.), certificazioni ambientali.
Perché è importante considerare l’impronta idrica del vino
- Consapevolezza ambientale: conoscere che dietro un semplice bicchiere di vino ci sono decine o centinaia di litri d’acqua aiuta a valorizzare la risorsa e ad agire in modo più responsabile.
- Sostenibilità aziendale: per i produttori vitivinicoli, ottimizzare l’uso dell’acqua può ridurre costi, rischi e migliorare la reputazione ambientale.
- Scenari futuri: con l’aumento delle condizioni di stress idrico in diverse regioni italiane e mediterranee, una viticoltura meno idro-intensiva diventa un fattore di resilienza.
- Comunicazione al consumatore: integrare il tema dell’acqua nella narrazione del vino può essere un valore aggiunto, specialmente per segmenti di mercato sensibili ai temi ambientali.
Fonti principali:
- “A Water Footprint Review of Italian Wine: Drivers, Barriers, and Practices for Sustainable Stewardship”, Water, 2020.
- “Water footprint and economic water productivity of Italian wines with …”, Science of The Total Environment, 2018.
- “Environmental Footprints of Red Wine Production in Piedmont, Italy”, Sustainability, 2025.
- “Cos’è la water footprint”, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2015.
Di Alessandra Calella