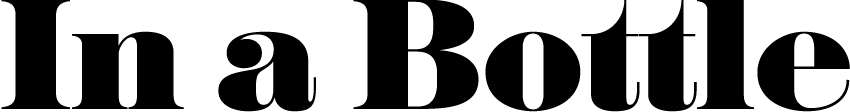MILANO - Che sia il rumore delle onde, la vista di un lago al tramonto o una semplice fontana in città, l’acqua ha un impatto profondo sulla nostra mente. Alcuni studi confermano che la presenza di corpi idrici migliora l’umore, riduce l’ansia e favorisce la concentrazione. Questo articolo esplora perché i cosiddetti “blue spaces” sono veri alleati del benessere quotidiano, e come la progettazione urbana possa integrarli per creare ambienti più sani, inclusivi e resilienti.
Il richiamo istintivo dell’acqua
L’essere umano è attratto dall’acqua per natura. Il concetto di biofilia, teorizzato dal biologo Edward O. Wilson, descrive la nostra tendenza innata a cercare connessione con gli ambienti naturali. Tra tutti gli elementi, l’acqua occupa un ruolo privilegiato. È parte del nostro corpo (in media per il 60%) ed è sempre stata al centro della nostra sopravvivenza.
Questa connessione profonda spiega perché la vista di un ruscello, il riflesso del sole sul mare o il rumore di una cascata suscitino sensazioni di calma, sicurezza e benessere.
Uno studio pubblicato su Health & Place (White et al., 2010) ha dimostrato che le persone che vivono vicino a specchi d’acqua hanno un rischio minore di sviluppare disturbi d’ansia e depressione. La semplice esposizione visiva all’acqua si associa a un miglioramento dello stato emotivo.
L’acqua nella mente: effetti misurabili
I benefici non sono solo percepiti, ma anche documentati a livello fisiologico e cerebrale. Il progetto europeo BlueHealth, coordinato dall’Università di Exeter e finanziato dalla Commissione Europea, ha raccolto tra il 2016 e il 2020 una mole significativa di dati che mostrano come i “blue spaces” – ovvero ambienti dominati dalla presenza di acqua – possano avere un impatto positivo sulla salute mentale.
In particolare, il contatto visivo e uditivo con l’acqua riduce l’attività dell’amigdala, una delle aree del cervello legate allo stress e alla reazione di allarme. Parallelamente, si osserva un incremento dell’attività nelle aree prefrontali, associate alla riflessione, alla calma e alla regolazione emotiva.
Camminare lungo un fiume, nuotare in mare o anche solo guardare la pioggia cadere può avere effetti comparabili a pratiche di mindfulness, aiutando il cervello a entrare in uno stato di “soft fascination” (Kaplan & Kaplan, 1989): uno stato di attenzione leggera, che facilita il recupero mentale e riduce il sovraccarico cognitivo.
Progettare con l’acqua: città più sane e inclusive
Negli ultimi anni, l’acqua è diventata un ingrediente chiave nella pianificazione urbana sostenibile. Non più solo risorsa da incanalare, ma elemento rigenerante e sociale. In città come Copenaghen, Barcellona o Rotterdam, canali, specchi d’acqua e giochi idrici sono stati integrati nei progetti urbani per migliorare il benessere dei cittadini.
Anche in Italia si osservano segnali positivi: gli spazi con acqua non solo offrono refrigerio durante le estati sempre più torride, ma diventano luoghi di aggregazione, interazione e tranquillità.
Un esempio concreto è l’intervento sulla Darsena di Milano: da area degradata è diventata uno dei cuori pulsanti della città, anche grazie alla valorizzazione dell’acqua come elemento estetico e identitario.
Ricordi, emozioni, senso di casa
Oltre agli effetti neurologici, l’acqua esercita una forte influenza a livello simbolico e autobiografico. Per molti, è associata a vacanze, momenti di libertà, giochi da bambini, contemplazione. È un vero e proprio “paesaggio interiore”, che risveglia memorie e sensazioni piacevoli.
Studi condotti dal Global Wellness Institute e da istituti di psicoacustica confermano che i suoni naturali dell’acqua (come onde, ruscelli, pioggia) aiutano a rallentare il battito cardiaco, ridurre la pressione arteriosa e indurre uno stato di calma profonda.
Non è un caso che moltissime app per il rilassamento – da Calm a Headspace – utilizzino questi suoni come colonna sonora per dormire meglio o praticare la respirazione consapevole.
Verso una “cultura dell’acqua” per il benessere collettivo
Alla luce di questi dati, appare chiaro che l’acqua vada considerata non solo come risorsa ambientale e industriale, ma anche come risorsa psicologica e sociale. Progettare spazi che la includano, tutelare i corsi d’acqua naturali, riqualificare le aree fluviali abbandonate: tutto questo significa costruire ambienti che favoriscano la salute mentale e l’inclusività.
In un mondo dove i disturbi legati allo stress sono in costante crescita, avvicinare le persone all’acqua – anche solo con fontane urbane, percorsi lungo i canali, piccoli laghetti nei parchi – può essere un passo concreto verso una società più sana.
L’acqua non solo disseta il corpo, ma rinfresca anche la mente. E forse oggi, più che mai, abbiamo bisogno di entrambe le cose.
Leggi anche: I laghi e i fiumi più sorprendenti del mondo
Di Martina Invernizzi