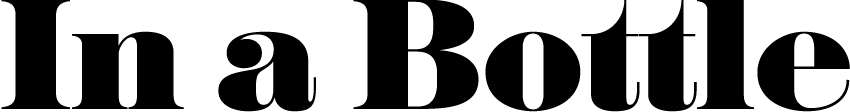MILANO - Il ghiaccio che si forma in natura o nei comuni freezer non è soltanto acqua congelata, ma il risultato di una precisa organizzazione molecolare. La sua struttura cristallina esagonale, unica tra le tante forme esistenti del ghiaccio, crea spazi vuoti che abbassano la densità complessiva, permettendogli di galleggiare sull'acqua. Un comportamento fisico anomalo, se confrontato con la maggior parte dei materiali, che assume un ruolo cruciale negli equilibri ecologici e climatici del pianeta. L’esistenza di altre forme di ghiaccio, più dense e meno familiari, offre uno sguardo affascinante sulle molteplici possibilità strutturali della materia solida.
Una forma solida con una densità sorprendente
Il ghiaccio comune possiede una struttura esagonale ordinata in cui le molecole d’acqua sono disposte secondo un reticolo che lascia numerosi spazi vuoti. Questa particolare configurazione si forma quando l’acqua si congela a pressioni e temperature standard. La disposizione delle molecole d’acqua è determinata dai legami a idrogeno, che impongono una distanza fissa tra le molecole, generando una forma solida meno densa dell’acqua liquida.
Dal punto di vista fisico, questo significa che il ghiaccio occupa un volume maggiore rispetto alla stessa quantità di acqua allo stato liquido, pur pesando lo stesso. È proprio questa bassa densità relativa che consente al ghiaccio di galleggiare, un comportamento piuttosto raro per una sostanza che passa dallo stato liquido a quello solido.
Una conseguenza essenziale per la vita sulla Terra
Il fatto che il ghiaccio galleggi ha implicazioni ambientali fondamentali. Nei laghi e nei mari delle zone fredde, il ghiaccio si forma in superficie e agisce come uno strato isolante, impedendo all’acqua sottostante di congelare completamente. Questo fenomeno consente la sopravvivenza della fauna acquatica durante i mesi invernali e contribuisce alla stabilità degli ecosistemi polari.
Se il ghiaccio fosse più denso dell’acqua, affonderebbe, e i bacini idrici ghiaccerebbero dal basso verso l’alto, mettendo a rischio la vita acquatica e alterando gli equilibri climatici. La geometria esagonale del ghiaccio, quindi, svolge un ruolo silenzioso ma determinante nell’equilibrio del pianeta.
Altri ghiacci, altre geometrie
Esistono numerose altre forme cristalline del ghiaccio, identificate come ghiaccio II, III, V, VI, fino ad arrivare a ghiaccio XIX. Queste strutture si formano in condizioni di alta pressione e bassa temperatura, come quelle presenti nei laboratori scientifici o negli strati profondi dei ghiacciai e dei pianeti ghiacciati.
A differenza del ghiaccio esagonale, molte di queste fasi hanno reticoli cristallini più compatti, privi di spazi vuoti significativi. Di conseguenza, la loro densità è superiore a quella dell’acqua liquida, e questi tipi di ghiaccio affonderebbero se immersi in essa. In particolare, il ghiaccio III e il ghiaccio VI sono esempi di fasi più dense, con legami molecolari più compressi e ordinati in simmetrie differenti.
Un equilibrio tra forma, forza e funzione
La geometria esagonale del ghiaccio rappresenta un caso di equilibrio perfetto tra stabilità strutturale e leggerezza. I legami a idrogeno mantengono ferme le molecole, ma allo stesso tempo creano una rete aperta che definisce la forma esagonale. Questo equilibrio conferisce al ghiaccio la capacità di galleggiare e lo distingue da altri solidi naturali.
La varietà di forme cristalline dimostra quanto l’acqua sia una sostanza eccezionale dal punto di vista fisico e chimico. Cambiando pressione o temperatura, le molecole si riorganizzano dando origine a nuove strutture con proprietà completamente diverse. Nonostante ciò, è il ghiaccio esagonale quello più rilevante per la vita terrestre, proprio grazie alla sua anomalia di densità.
Leggi anche: Perché il ghiaccio galleggia sull'acqua
Di Martina Invernizzi